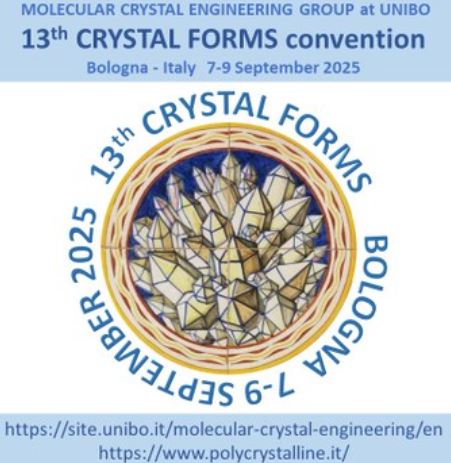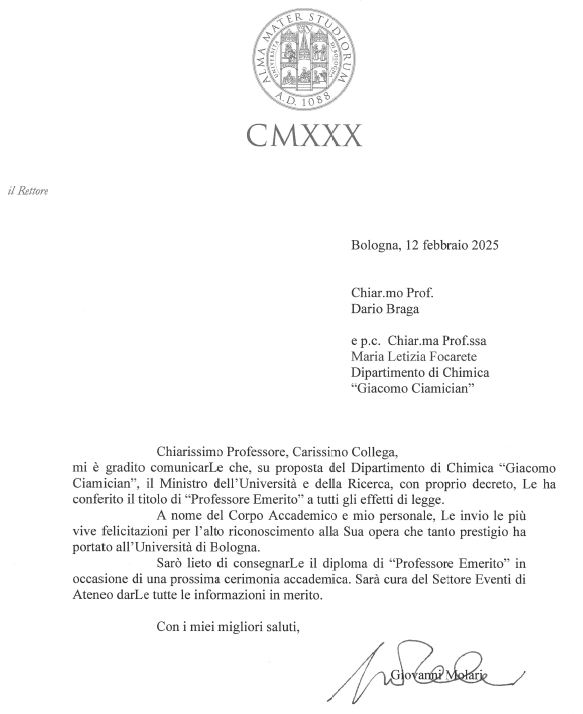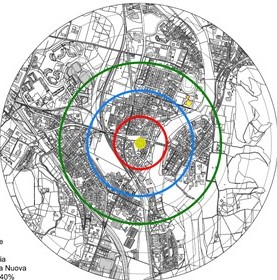Articoli pubblicati sul Sole 24 Ore nel 2023, il tema di riferimento è come sempre l’università italiana
Le scelte inderogabili per rendere l’università capace di attrarre i giovani
26 settembre 2023
Stanno riprendendo i corsi universitari. Abbiamo chiuso il secondo semestre con il tema del caro-affitti e con studenti fuori sede accampati davanti ai rettorati di numerose grandi università. La stampa si è occupata a lungo del problema legandolo anche a quello degli abbandoni, che ha visto un record del 7.4 % per l’anno 2021-2022. I dati provvisori del 2 2-23 mostrano una lieve inversione di tendenza con un aumento del 2.2% rispetto al 21-22. Il che è un buon segno, ma che non sposta il fatto che in Italia quasi il 20% dei giovani tra 15 e 19 anni non studia e non lavora. Il dato dell’Italia, insieme a quello della Romania è il peggiore di tutta l’unione europea. Se poi si considera che il 42% dei giovani europei tra 25 e 34 anni è laureato mentre per l’Italia si arriva al 29.2%, il quadro è fosco.
Abbandoni e basso numero di giovani che si iscrivono all’università hanno cause diverse e profonde. La scarsa capacità di attrazione dell’università italiana non può essere spiegata solo dai costi dello studio (alloggio certo, ma anche spostamenti, tasse universitarie, spese vive ecc.). Vero è che il costo dell’istruzione universitaria in Italia è, stando ai dati OCSE, cresciuto notevolmente portandoci verso i valori alti, ma è anche vero che tutte le università hanno piani di riduzione delle tasse universitarie in funzione del reddito.
Partiamo dalla domanda ovvia. Perché “andare all’università”? Fino a qualche anno fa, la risposta immediata sarebbe stata una di due tipi.
Vado all’università perché “è ovvio che lo faccia”. Perché la mia famiglia, il mio ambiente, i miei amici sono laureati o stanno studiando, e la laurea servirà a mantenere, o migliorare, il mio status attuale.
Oppure, vado all’università perché “con la laurea starò meglio”. Meglio rispetto alla condizione lavorativa dei miei genitori e parenti, meglio rispetto alla mia attuale collocazione sociale e rispetto alla possibilità di soddisfare i miei desideri e/o di raggiungere i miei obiettivi personali. Il così detto “ascensore sociale”: potrò fare un lavoro più soddisfacente, guadagnerò di più, oppure potrò fare un’attività con maggiori ricadute sociali, ecc.
Da un certo punto di vista entrambe queste motivazioni sono entrate in crisi. Che l’“ascensore sociale” si sia bloccato è abbastanza chiaro. La laurea non comporta (più) un reddito maggiore. Si pensi a quanto guadagnano gli insegnanti, forse la categoria più vasta di laureati nel Paese (oltre 900.000 con stipendi netti/mese tra 1.400 e 2.000€). La laurea nemmeno garantisce più un maggiore riconoscimento sociale. I modelli di riferimento del “successo” sono altri.
Una terza ragione per andare all’università potrebbe anche essere la sola passione per lo studio e per la ricerca, magari il sogno di diventare ricercatrice o ricercatore. Ma, nell’ immaginario collettivo lo scienziato non è più lo scopritore o l’inventore o lo studioso. Una complessa e sistematica opera di demolizione della fiducia nella scienza ha sostituito l’immagine dello studioso e del ricercatore con quello del cervello in fuga e/o del precario, comunque sottopagato, e destinato a una vita di incertezza.
Non ci si può quindi sorprendere se i giovani sono meno attratti dallo studio e se le stesse famiglie di provenienza sono meno disposte che in passato a “fare i sacrifici” necessari per mandare i figli a studiare …
Come siamo arrivati a questo?
E’ colpa dei media? E’ colpa di un modello di società ripiegata sulla mediocrità e sulla logica del “furbetto di turno”? E’ colpa di una classe dirigente che non riesce ad andare al di là dell’incasso elettorale a breve? E’ colpa di imprenditori che hanno rinunciato a innovare? Attribuire colpe è uno sport nazionale, che spesso non porta a nulla.
Semmai possiamo chiederci cosa possiamo fare per rilanciare la capacità di attrazione dello studio universitario in Italia. Anche solo per tentare una risposta servono ragionamenti troppo complessi e troppo scomodi per essere sviluppati in poche righe, ma qualcosa si può dire.
In primo luogo, serve investire sulla residenzialità universitaria (che fine ha fatto il censimento avviato dalla Ministra Bernini?) e non solo per sostenere la mobilità interna, che oggi si scontra con il successo turistico delle nostre città universitarie, ma anche per consentire la presenza di studenti da altri paesi. Gli studenti stranieri incontrano difficoltà ancora maggiori nel trovare alloggio nelle nostre città. Non va dimenticato che la circolazione internazionale è fondamentale per l’università, è nel suo DNA, ma lo è anche per il Paese. L’immigrazione intellettuale può essere uno strumento strategico di mediazione culturale con l’immigrazione meno istruita.
Inoltre, visto che abbiamo un grosso problema di fruizione degli insegnamenti universitari per via dei costi degli alloggi e degli spostamenti, possiamo lavorare sul modello della didattica mista, in presenza e online. Abbiamo tutte/i imparato a usarlo e lo abbiamo riscoperto in occasione della catastrofica alluvione in Romagna. Certo, il sistema misto è – per sua natura – disuguale. Ma è forse egualitario selezionare gli studenti sulla base del fatto che possano permettersi o meno una stanza in affitto? Nelle Università la creatività non manca, si studi il modo per colmare il “divide” generato dalla didattica mista. Le soluzioni fantasiose si trovano, se si riconosce l’importanza di portare i giovani allo studio. L’emergenza sappiamo già come gestirla, impariamo a trasformarla in innovazione. La resilienza si vede anche qui.
Altro intervento emergenziale, con effetto immediato, è quello dell’abbattimento delle tasse universitarie. Tema sul quale ho già scritto (si veda Sole del 4/11/22). Abolire, o ridurre in modo sostanziale, le tasse universitarie è uno strumento potente per favorire l’accesso alla formazione universitaria dei giovani italiani, al di là del censo e della fedeltà fiscale. Sarebbe anche più equo: in un paese che ha una evasione fiscale di 100 miliardi di euro, la probabilità che acceda ai pochi benefici (alloggi, borse di studio ecc.) anche chi non lo merita a scapito di chi le tasse le paga veramente è molto alta.
E comunque, “alla fin della fiera”, la capacità di attrazione dello studio universitario dipende anche, e in modo sostanziale, dalla valorizzazione degli obiettivi raggiunti con la formazione. E il miglior modo per riconoscere l’impegno e il merito, nello studio, nella ricerca, nell’insegnamento e nella missione sociale è, in primis, quello di retribuirli in modo adeguato.
La burocrazia digitale che frena l’Università
«La burocrazia è male endemico del nostro Paese ma il combinato-disposto del Pnrr (più ministeri coinvolti) e della declinazione digitale la rende spesso impenetrabile e irreversibi … di Dario Braga L’università italiana sta vivendo un momento di grande fermento. Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per la prima volta dopo molto tempo, le risorse abbondano. Questa è ovviamente una gran buona notizia. Tuttavia, ci sono anche conseguenze meno positive. L’arrivo dei fondi Pnrr ha messo sotto stress i ministeri, a partire dal Mur, e, di conseguenza le amministrazioni universitarie. È stato, ed è, necessario ripartire risorse in pochissimo tempo e avviare processi di spesa e di rendicontazione complessi. Si pensi che la sola ammissione al dottorato di ricerca ha richiesto quattro concorsi, e tutti sostanzialmente per lo stesso ciclo, con bandi che hanno coinvolto anche amministrazioni diverse e un grande numero di imprese. Una seconda ondata di borse sta per riversarsi sugli Atenei. Per non parlare dei finanziamenti per posti di ricercatore a tempo determinato, e dei progetti nazionali di ricerca “hub and spoke”, ecc. Purtroppo, i tempi molto stretti stanno trasformando l’utilizzo delle risorse in un incubo amministrativo. L’indispensabile ricorso a strumenti informatici sta portando a una frenetica “burocratizzazione digitale”. Una burocrazia che va ad appesantire, invece di ridurre, una situazione di sofferenza burocratica già più volte denunciata. Già oggi, moltissime operazioni che venivano tradizionalmente compiute attraverso l’intermediazione amministrativa (es. appelli d’esame, prenotazioni di aule e spazi, missioni e procedure d’acquisto, rendicontazioni, commissioni di laurea e di dottorato, ecc.) vengono svolte dal singolo docente. Singolo docente che si deve anche preoccupare di aggiornare continuamente. I dati con cui alimentare i processi di valutazione attivati da Anvur e le banche dati Mur. La “dematerializzazione digitale” ha portato, in moltissime situazioni, a una lievitazione della documentazione («tanto è solo un pdf da caricare»). Un esempio? Le «linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi del Pnrr Italia di cui il ministero dell’Università e della Ricerca è amministrazione titolare» consta di 60 pagine, sessanta. Le procedure previste, sebbene informatizzate, sono spesso arzigogolate, complesse e ripetitive e ricadono largamente su quel personale docente e di ricerca (i così detti «soggetti attuatori») che dovrebbe occuparsi prioritariamente dell’ottenimento dei risultati di ricerca e non della burocrazia precedente e di quella conseguente. Un piccolo estratto dalle linee guida: «Il Soggetto Attuatore (…) accedendo al sistema ReGiS deve generare e validare sul sistema del Mef il Rendiconto di progetto ReGiS, aggregato in tal caso a livello di singolo Cup, selezionando le medesime borse già approvate e presenti nel Rendiconto trasmesso al Mur, di cui al paragrafo precedente». Sono convinto che ChatGPT (il software di AI con cui tutti si stanno cimentando al momento) scriverebbe istruzioni più chiare. Intendiamoci, la burocrazia è male endemico del nostro Paese (e non solo del nostro) ma il combinato-disposto del Pnrr (più ministeri coinvolti) e della declinazione digitale la rende spesso impenetrabile e irreversibile (non c’è un volto umano con il quale dialogare di là dallo schermo). La frenesia digitale della burocrazia ha in sé un problema: la produzione “in continuo” di nuove interfacce non consente di mettere sufficientemente alla prova le nuove procedure prima che del loro varo. Spesso l’utente – il «soggetto attuatore» – si trova davanti a maschere user un-friendly, quando non ostili. Credo che non si tratti di un problema di scarsa professionalità informatica quanto di schizofrenia e mancanza di supervisione. La regola aurea dovrebbe essere quella di non consentire il rilascio di procedure senza la verifica preventiva da parte di utilizzatori finali. Chi costruisce la procedura si preoccupa che funzioni e spesso dimentica (vedi sopra) che chi la deve utilizzare ha ben altre competenze. Inutilmente continuiamo a ripetere che, se docenti e ricercatori devono investire una parte cospicua e crescente del loro tempo in ossessive rendicontazioni e nell’adempimento di operazioni amministrative “delegate”, non possono fare il lavoro per cui sono stati reclutati: fare ricerca, e fare didattica, aggiornarsi, studiare, scrivere ecc.. Tantomeno possono far fruttare bene gli investimenti del Pnrr. Qualcuno dovrebbe ricordarlo anche alle dirigenze ministeriali.
Le università italiane e il paradosso dei troppi indicatori
15/02/2023
È una corsa ragionieristica ai risultati, ma non è detto che si selezioni il profilo più adatto L’opinione L’università italiana è ormai entrata in una nuova era, che potremmo chiamare del “parametrocene”
L’università italiana è ormai decisamente entrata in una nuova era, l’era che potremmo chiamare del “parametrocene”.
Da qualche anno stiamo assistendo alla proliferazione di indicatori e parametri per lo più associati alla valutazione della performance in termini di ricerca, didattica e, più di recente, anche di terza missione del sistema universitario, quando non dei singoli docenti.
L’arrivo delle ingenti risorse del PNRR, e quindi la necessità di spenderle presto e bene, stanno contribuendo ad accelerare il processo di transizione. Era ora che l’università italiana uscisse dalla discrezionalità e dalla opacità e adottasse una logica e una prassi di “accountability” con procedure fondate su criteri trasparenti e su parametri verificabili.
Ma siamo sicuri che tutto vada bene? Vedo due conseguenze negative della ipertrofia parametrica caratteristica del “parametrocene”: da un lato, le ricadute sui processi di reclutamento, di selezione e di promozione universitaria a qualsiasi livello, dal ricercatore all’ordinario, e, dall’altro, la lievitazione di una burocrazia informatizzata ancora più pervasiva ed impenetrabile della burocrazia cartacea.
In questo intervento mi concentro sul primo tema, perché l’uso estremo di indicatori e parametri nei processi di selezione e di promozione di ricercatori e professori universitari sta mutando non solo il modo di selezionare ma anche, e questo è peggio, le priorità che i più giovani sono costretti a darsi per non essere penalizzati nelle loro carriere.
Una premessa è d’obbligo, tuttavia. Chi scrive appartiene alla generazione di docenti universitari che ha spinto fortemente perché la comunità accademica adottasse “parametri oggettivi” nella valutazione della produzione scientifica e dell’output di ricerca del personale da reclutare e promuovere. La motivazione era forte: occorreva incrinare, se non già scardinare, la autoreferenzialità di molte commissioni di concorso. Autoreferenzialità che spesso portava a scelte distorte, o ingiuste, come testimoniato da una lunga – mai interrotta – sequenza di contenziosi accademici quando non giudiziari.
L’introduzione di indicatori come “impact factor”, “citation index”, “H-index” ecc. per misurare in modo oggettivo il grado di apprezzamento da parte della comunità internazionale del lavoro di ricerca, doveva servire ad aumentare la trasparenza dei processi decisionali da parte delle commissioni di concorso. L’obiettivo finale era quello di spingere a scelte palesi e responsabili che, nella selezione, tenessero conto apertamente sia dei curriculum vitae sia delle esigenze strategiche e dei piani di sviluppo della ricerca di una struttura. Il termine “oggettivo” entrava così nel lessico della valutazione della ricerca dei candidati nei concorsi universitari.
Non lo sapevamo, ma stava iniziando il “parametrocene”: alla valutazione parametrica delle pubblicazioni scientifiche da lì a poco si sarebbe aggiunta una pletora di nuovi indicatori: numero di ore di lezione, di ore di tutorato, di dottorato, numero di studenti in tesi, suddivisi tra triennale, magistrale, e dottorale, e poi numero di convegni e di conferenze, se nazionali o se internazionali, numero di ore di attività di terza missione, premi e menzioni, numero di brevetti, numero e importanza degli incarichi gestionali ecc. Un messaggio preoccupante a chi è in carriera: meglio darsi da fare per aumentare la quantità di indicatori favorevoli che non la qualità del proprio CV.
Le commissioni di concorso sono ora chiamate a un lavoro ragionieristico (non me ne voglia la categoria) di somme e prodotti che non ha nulla a che vedere con la scelta ragionata di chi sia più adatta/o a coprire una certa posizione in un dipartimento universitario o possa contribuire meglio a sviluppare o consolidare una ricerca o una linea di studio.
Bene hanno fatto alcuni atenei a spostare in capo ai consigli di dipartimento la scelta finale tra una rosa di idonei. Vedremo se le dinamiche dipartimentali consentiranno veramente che prevalgano gli interessi dell’istituzione. Se non altro, le chiamate dei professori saranno, nel bene o nel male, il risultato di una assunzione di responsabilità collettiva e non di una gara a punti.
Dario Braga